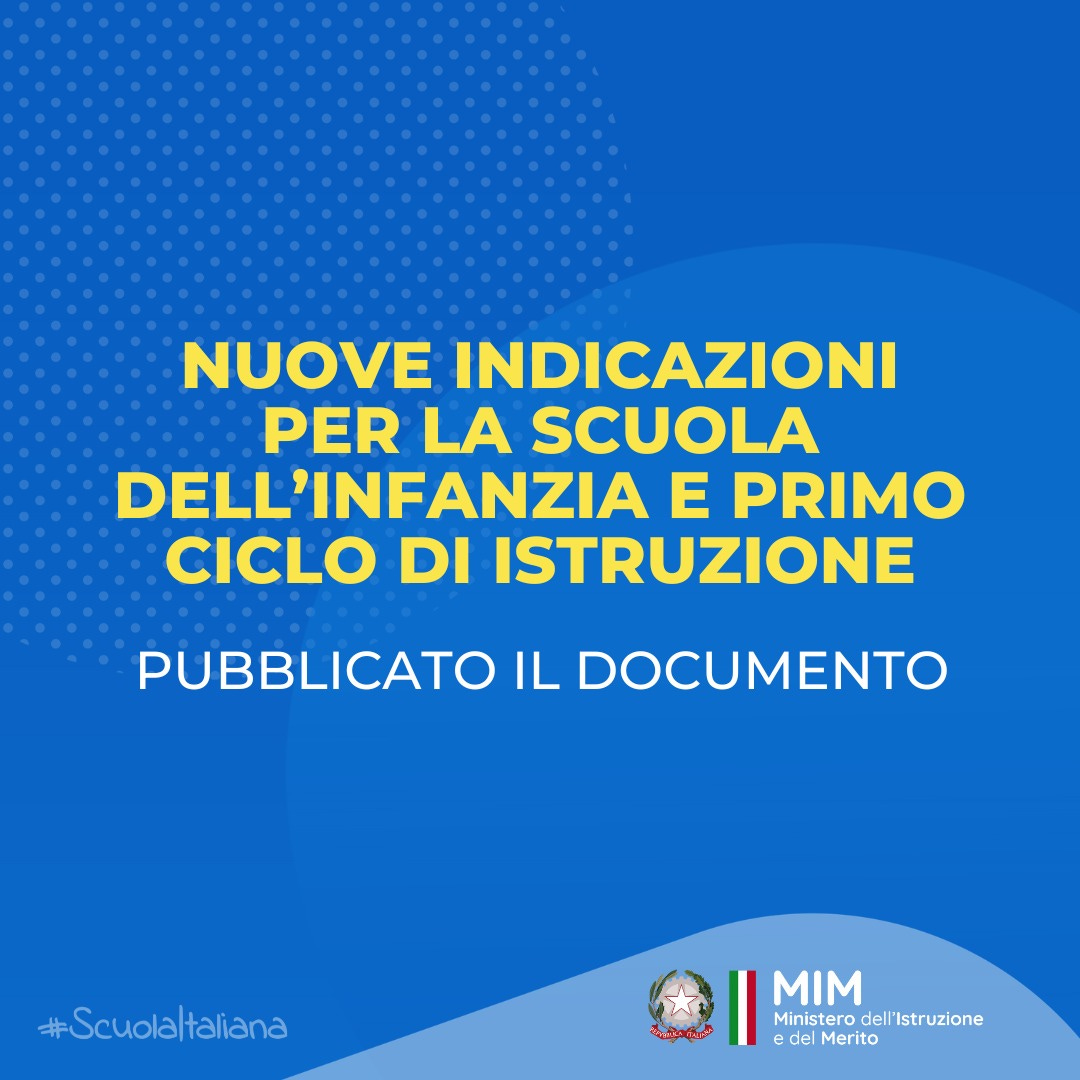Bilanci
Di cosa parleremo nell’ultimo numero di questo anno scolastico? La parola che emergerebbe per prima è stanchezza. Ma non vorrei concludere così un anno che ha portato tanto con sé: tra un PNRR e l’altro, molte iniziative, molti cambiamenti, molte emozioni lo hanno arricchito e quindi preferisco sintetizzarlo con la parola ricchezza. Di esperienze, di novità e di tutto.
Oceani idee generative per una scuola che vuole ricominciare a nuotare in alto mare
Servivano Nuove Indicazioni Nazionali?
Partiamo da qui, senza mezzi termini. La diffusione della bozza del nuovo documento ha suscitato accesi dibattiti, di cui provo a fare il bilancio attraverso una rassegna stampa ragionata.
Erickson editrice al tema ha dedicato un intero volume, dal titolo eloquente: Credere Obbedire Insegnare, Voci critiche sulle Indicazioni Nazionali 2025 per il primo ciclo di istruzione. Leggiamone qualche passo:
Nel documento diffuso a marzo c’è un intero paragrafo “Scuola e nuovo umanesimo" (pag. 10) con argomentazioni che riprendono le precedenti Indicazioni nazionali, e con rinvii a concetti come inclusione, Costituzione, contrasto alla dispersione. Lasciano, però, non pochi dubbi in chi scrive, alcuni passaggi come: l’idea di principio di autorità, il richiamo al senso del limite, l’auspicato sviluppo dell’etica con l'acquisizione delle "regole", il concetto morale di regola che si forma anche attraverso le “regole tratte dai contenuti e dai metodi delle stesse discipline, come p.e. le regole di grammatica”.
Il Centro Studi per la Scuola Pubblica nota:
Un forte baricentro sulla cultura nazionale (la parola “occidente” o “occidentale” compare 26 volte) come fondamento dell’identità da trasmettere alle classi, senza alcuna apertura agli aspetti multiculturali della nostra società e all’idea di una costruzione interculturale e interattiva del sapere. Emblematica è la frase di apertura del curricolo di storia che perentoriamente asserisce: “Solo l’Occidente conosce la storia”. Un testo che mira senza nasconderlo ad imporre una nazionalizzazione delle/degli studenti con background migratorio.
Si richiama l’impegno alla “personalizzazione” (24 volte) come strategia educativa di accompagnamento nello sviluppo dei “talenti”. Tale ottica si pone nella prospettiva di ‘fotografare’ e sviluppare in ogni allievo e allieva le caratteristiche assunte dal contesto socioculturale di provenienza invece di impegnare la scuola a contrastare i limiti ereditati dal contesto sociale e a promuovere la realizzazione di ogni studente in relazione con le altre persone. La reintroduzione facoltativa del latino appare emblematica di questo uso dei presunti “talenti” come mascheramento di una precoce differenziazione dei percorsi.
Sull’idea di alunno che viene sottesa leggiamo quanto afferma La Società italiana di Pedagogia:
La visione di bambine/i e ragazze/i che si propone è quella di soggetti sostanzialmente incompetenti, fragili, dei quali si evidenziano soprattutto i comportamenti problematici (es. p. 9 o p. 11) e ai quali l’insegnante eroga le conoscenze. Non rinvenibile il richiamo ad un’ampia letteratura scientifica sulle competenze dei discenti (es. un repertorio multilingue, competenze digitali, o di gestione dei conflitti), spesso invisibili all’istituzione, né la prospettiva di un bambino che naturalmente desidera imparare e di un insegnante che ha come compito principale quello di non soffocare questa naturale ricerca di senso.
Puntuali critiche all’impostazione delle discipline provengono dalla Società Italiana delle Letterate.
Nel dibattito sulla storia, una delle parti più controverse, è intervenuta anche la Rete di Scuole Senza Zaino:
La Storia, per gli estensori delle Indicazioni 2025 “non può prestarsi a nessuna manipolazione creativa da parte degli studenti” e “per quanto si voglia rendere interessante il racconto storico esso deve essere anzitutto conosciuto attraverso la spiegazione dell’insegnante o le pagine scritte di un libro”.
Emerge, in particolare
la rivendicazione dell’inutilità della lettura e analisi delle fonti, della pluralità di interpretazioni storiografiche e delle riflessioni sui grandi temi, a favore di una non meglio precisata “dimensione narrativa” della storia che è, naturalmente, univoca e in primo luogo italica. (contributo di Scosse)
Ma non mancano voci di dissenso anche sull’arte, sulla matematica, sul tema della disabilità.
Osservazioni puntuali anche da parte dell’Associazione Italiana Dislessia.
Saperi costituiti, elargiti dalla figura del Magister, talenti individuali considerati come qualità innate e dunque geneticamente o socialmente favorite, visione ristretta delle discriminazioni (non una parola su quelle omofobe o razziste per esempio), sviste sui contenuti (Il Trono di Spade come serie suggerita per un percorso letterario), occidentalismo e sessismo serpeggianti sembrano le caratteristiche salienti del nuovo documento. Di cittadinanza multiculturale e nuovo umanesimo (Morin) neanche l’ombra. Spuntano invece qua e là cenni giustapposti su disciplina, autorità, rispetto dei docenti e delle norme, come a voler far coincidere autoritarismo ed educazione. Qui un’altra disamina circostanziata.
Isolotti libri, film, documenti come terre emerse dove riposare, interessanti per chi insegna, per chi desidera approfondire educazione, didattica, inclusione, apprendimenti
Lettera aperta di una studentessa del Liceo Lugo di Romagna
L’incipit:
Cari professori,
è quasi un peccato essere arrivati così in basso da trovar necessario scrivere una lettera, ma non vi vedo soluzione. Secondo la cultura giapponese ogni persona dovrebbe possedere un ikigai, cioè uno scopo nella vita, quel qualcosa che ti fa svegliare la mattina. Bene, io l’avevo trovato nello studiare, lo facevo con passione, quasi devozione. Mi svegliavo la mattina consapevole che andare a scuola, imparare, studiare fosse il mio scopo. Poi ho iniziato a comprendere, ogni giorno di più, che non ha alcuna utilità: di utile, non mi viene spiegato nulla in modo appassionante, non vengo mai ricompensata per il duro lavoro. Quando arrivo a casa e devo aprire il libro per studiare mi viene da piangere, sento la mia mente chiudersi, bloccarsi. Quando sono in classe sento solo morte, mi guardo attorno e vedo i miei compagni con gli occhi spenti o addormentati, guardo verso di voi e vedo il nulla, solo una specie di automa che sputa parole su fatti decaduti i cui valori nascosti sono stati sepolti con le loro vittime.
Che si risponde a un bilancio del genere? Prima reazione, normale: non è sempre così, noi non siamo così, sta parlando ad altri… non mi riguarda. Sicuri? Continuiamo la lettura:
Mi domando perché la mattina mi sono alzata per andare in un luogo dove nessuno mi vede, dove nulla mi interessa, dove si è solo di fretta e in ansia per finire un programma che nessuno sa davvero perché segue, dove mi giudicate per quindici minuti e mettete sul registro un voto immotivato su qualcosa che mi avete spiegato in modo freddo, distante e morto. Pretendete un albero altissimo, meraviglioso, possente, ma non vi curate un minimo di innaffiarlo, di fertilizzarlo, di assisterlo con un bastoncino quando il fusto è troppo fragile.
In qualche cenno qui forse qualcuno comincia a riconoscersi? Per lo meno in alcune manifestazioni tipiche della fine dell’anno: la corsa al programma, l’ansia e la fretta di concludere, il ciclo eterno spiegazione-interrogazione, la mannaia del voto. Vi lascio con le domande finali:
Ho delle domande per tutti voi, siate sinceri almeno con voi stessi, perché insegnate? Quando ci guardate cosa vedete? Credete che essere insegnanti sia un lavoro sociale?
Proviamo sinceramente a rispondere a queste domande e anche a quelle sottese nel testo perché mettersi in discussione, alla luce di quanto ci viene restituito dagli altri, fa sempre bene. Qui una bella risposta.
Correnti lungo le quali anche i genitori potranno ricaricarsi, seguendo il flusso
Voti a scuola: sì o no? La vera domanda è un’altra. Così si intitola un recente post di Alberto Pellai, neuropsichiatra specializzato in adolescenza:
Scandagli citazioni alla ricerca di ispirazione
Bilancio. Mai in equilibrio. Gustave Flaubert
Onde strategie, attività, progetti per movimentare la didattica
Fatevi un giro sul sito del Movimento di Cooperazione educativa, offre spunti molto interessanti, anche come antidoto al clima delle Indicazioni di cui sopra.
Liber Liber, piattaforma che mette a disposizione libri e audiolibri i cui diritti d’autore sono scaduti, compie 30 anni.
E poi c’è Linda, una piattaforma AI per migliorare l'analisi e la comprensione del testo attraverso l’annotazione linguistica.
Immersioni proposte e segnalazioni di iniziative e cose utili
Vi lascio qualche lettura per i mesi estivi, dato che ci risentiremo a settembre ( a meno che non abbia qualcosa di interessante da comunicare prima):
Gli universitari non studiano (quasi) più sui libri?
L’equilibrismo della maternità in Italia
Sulla crisi climatica, l’esempio di Barcellona
Deviazioni digressioni, sconfinamenti, frivolezze; perché abbiamo bisogno di uscire fuori dai margini delle mappe, magari perdendoci, per poi ritrovare la rotta
Sconfiniamo su un argomento tabù, i soldi. Sulla gestione di guadagni e risparmio vi consiglio la newsletter di Rame (le conversazioni sui soldi che non hai mai avuto). E se volete prima farvi un’idea vi lascio i link a due articoli a tema viaggi:
Come risparmiare davvero sui biglietti aerei
Viaggiare senza spendere un patrimonio
Arrivederci a settembre!
Foto mie (solo la seconda tratta dal sito del MIM)